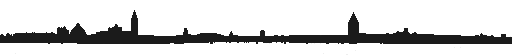|
www.archeosub.it |
|
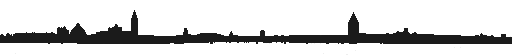
A.I.A.Sub
Associazione Italiana Archeologi Subacquei
![]()
|
www.archeosub.it |
|
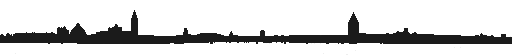
A.I.A.Sub
Associazione Italiana Archeologi Subacquei
![]()
Da L'Archeologo Subacqueo (set-dic 2001) a cura di Alessandra Benini e Marta Giacobelli e da Archeologia Viva (anno XXI n. 93 n.s. mag-giu 2002) a cura di Franca Cibecchini (parzialmente rielaborati)
A distanza di cinque anni dal primo incontro (Anzio 1996), si è svolto a Castiglioncello nei giorni 7-9 settembre il 2° Convegno di archeologia subacquea organizzato dall'A.I.A.Sub e dal Comune di Rosignano Marittimo (LI), in particolare dal locale Museo civico.
Interventi:
Il villaggio delle Macine: indagini nel lago di Albano (Castelgandolfo RM) di Annalisa Zarattini (Soprintendenza archeologica del Lazio) e Micaela Angle intervento relativo alle indagini subacquee sul villaggio detto delle Macine", abitato, risalente al Bronzo medio (1700-1600 a.C.) e ritenuto il più importante insediamento palafitticolo di questa età.
Nel fondale vi sono infissi numerosi pali lignei, associati anche a molti frammenti di ceramica, la cui maggiore concentrazione è stata riscontrata intorno a 3 metri di profondità; il rilievo ha reso leggibile la complessa disposizione di 86 pali, rivelando alcune tecniche costruttive caratteristiche (come quella del "rinzeppamento" o affiancamento di più pali) ed individuando possibili allineamenti.
Nella fascia batimetrica intorno ai 9 metri sono stati invece riscontrati oggetti di ceramica integri e associati ad elementi lignei con apparenti tracce di fuoco o carbonizzati, Tale differenza è probabilmente dovuta alla minore energia del moto ondoso alle maggiori profondità, dove è anche più difficile il prelievo clandestino. Dal lago proviene anche una cospicua produzione metallurgica, assegnabile agli inizi della media età del Bronzo, rappresentata da asce che mostrano evidenti tracce di usura.
Il tipico ambiente asfittico e umido ha poi conservato resti carpologici, come alcune corniole 'mummificate" che hanno mantenuto la polpa e il contenuto resinoso dei semi, cereali e gusci di nocciola carbonizzati. Inoltre, dall'interno di una ciotola proviene un amalgama compatto, di matrice minerale, contenente cariossidi e spighette di Hordeum volgare. L' analisi archeozoologica di centinaia di resti ossei ha infine rilevato la presenza di molte specie: è testimoniata anche la raccolta delle tartarughe, come indica la presenza di una piastra nucale del carapace. Su due elementi è stata riscontrata la lavorazione dell'osso: un punteruolo e forse un pendaglio.
Indagini subacquee a Jasos (Caria) Le prospezioni subacquee condotte negli anni 1998 e 2000 a lasos di Caria, sulla costa dell'Anatolia, presentate da Paola Desantis (Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna ) e Fede Berti (Museo archeologico di Ferrara), hanno localizzato un accumulo di materiali, prevalentemente anfore di tipo "Kos", databili fra I sec. a.C. e I sec. d.C., interpretabile come carico di un relitto oppure come deposito portuale. Le strutture, ora sommerse, corrispondono a quelle del porto orientale, il più ampio, dell'antico insediamento di Iasos frequentato dal Neolitico sino all'epoca Bizantina.
La posizione di lasos, che occupava anticamente un'isola poi congiunta alla terraferma da un istmo, consentiva di usufruire di due approdi. L'insediamento è segnato da una precoce frequentazione greca e manifesta, in età arcaica, forti connessioni con l'ambiente ionico, Milesio in particolare. Su entrambi gli approdi si concentrano funzioni civili e religiose caratterizzanti: da un lato gravita l'importante santuario di Zeus Megistos, dall'altro l'agorà ellenistica e imperiale. Allo stato attuale delle conoscenze i due porti presentano una diversa conformazione; il porto occidentale, chiuso da due moli, è dotato di alcuni apprestamenti, a differenza di quello orientale, assai più ampio, E tuttavia proprio lungo il lato orientale della penisola che le recenti prospezioni hanno individuato un accumulo coerente di materiali in posto, costituito prevalentemente da anfore di tipo 'Kos" (I a.C.- I d.C.), accumulo la cui natura sembrerebbe riconducibile al carico di un relitto oppure ad un deposito pertinente a strutture portuali ora sommerse.
Archeologia subacquea a Vada Volaterrana: il porto, i relitti, i commerci alla luce delle recenti acquisizioni - M. Pasquinucci e S. Menichelli (Università di Pisa) hanno presentato una sintesi sulle ricerche relative al porto di Vada Volaterrana, attivo dall'età ellenistica III-II a.C.) al VII sec. d.C., e al quartiere portuale in corso di scavo in località S. Gaetano di Vada (Rosignano Marittimo - LI), dove in età flavia (I sec. d.C.) venne costruito un quartiere connesso con il vicino porto: al momento sono stati portati in luce due complessi termali, un horreum (magazzino), un probabile macellum (mercato), una fontana monumentale e un edificio a destinazione artigianale.
Ricerche integrate tuttora in corso (studio delle fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche, analisi dei dati geomorfologici, indagini subacquee, applicazione di telerilevamento) forniscono nuovi elementi per la localizzazione e la conoscenza del porto di Vada: operazioni di imbarco e sbarco merci venivano effettuate nel tratto di mare, protetto dalle secche, antistante la costa fra la Punta di Pietrabianca e la Punta del Tesorino; un bacino ridossato, il vero e proprio porto, può invece essere localizzato in prossimità dell'attacco dell'attuale pontile della Soc. Solvay.
In loc. S. Gaetano di Vada, al di sopra degli strati di distruzione di un villaggio databile al IX sec. a.C., venne pianificata in età flavia la costruzione di un quartiere funzionalmente connesso con il vicino porto, di cui al momento sono stati portati in luce due complessi termali, un horreum, un probabile macellum, una fontana monumentale ed un edificio a destinazione artigianale.
Sulla base delle evidenze archeologiche e letterarie, è così possibile formulare ipotesi sui collegamenti commerciali in cui fu coinvolto il porto di Vada Volaterrana, dall'età ellenistica al VII sec. d.C.
Il porto romano in località Puntone di Scarlino (GR): indagini archeologiche subacquee e porti moderni. di Sergio Bargagliotti e Franca Cibecchini (A.I.A.Sub e Università di Pisa). In località Puntone di Scarlino (CR) si è concluso lo scavo del bacino portuale dell'antico Scabris portus, a cura del Nucleo operativo subacqueo della Soprintendenza archeologica della Toscana e di alcuni archeologi subacquei. L'intervento, occasionato dalla costruzione di un moderno porto turistico ha messo in luce le varie fasi di frequentazione del bacino. Tra i rinvenimenti si evidenzia un gruppo di anfore greco-italiche (fine III - inizi II sec. a.C.), ceramica da cucina e da mensa molto omogeneo, interpretato come ripulitura del carico di una nave commerciale romana, forse dopo aver effettuato una sosta di scarico nello stesso porto.
La località, forse identificabile con il toponimo Portus Scabris noto dall Itinerarium Maritimum, è già nota per i numerosi siti archeologici d'epoca romana, tra cui ville e centri di lavorazione del ferro. Le prospezioni effettuate nel bacino, prima e durante le operazioni di escavo, hanno evidenziato due aree di maggiore interesse. Nella prima sono stati scavati due siti: nel primo (denominato Pulvino 28 o relitto C) è stato messo in luce un frammento di scafo ligneo, assemblato a mortase e tenoni) nel secondo (denominato Pulvino 24), è stato eseguito un saggio che ha permesso di ricostruire la sequenza stratigrafica, compresa tra l'età tardo repubblicana e l'età moderna, di questa porzione dell'antico bacino portuale.
La seconda area (denominata sito B) ha restituito un ampio giacimento di materiale archeologico databile ad età tardo repubblicana ed alcune porzioni dello scafo ligneo di una o più imbarcazioni.
Le indagini finora svolte hanno permesso quindi di individuare alcune aree del bacino portuale romano, di precisare la datazione di formazione e di utilizzo dello scalo antico, nonché di individuare parti di imbarcazioni naufragate o abbandonate nel porto.
Il giacimento archeologico del porto di Cagliari Donatella Salvi (Soprintendenza archeologica di Cagliari) In occasione dei lavori di manutenzione per l'ormeggio delle navi a breve distanza dalla banchina di via Roma, alcune ricognizioni hanno portato alla luce un imponente deposito archeologico risparmiato, almeno in parte finora, dai dragaggi.
Già in passato, lungo i moli, altri ritrovamenti avevano fatto percepire l'entità e le potenzialità di questi giacimenti, non appena gli interventi condotti con le draghe, intaccando i fondali fangosi, consentirono il recupero non solo di anfore, ma anche di oggetti di coroplastica di notevole interesse. Pur distanti fisicamente dalla località di Su Moguru - situata più a nord della laguna di Santa Gilla - che nell'Ottocento consentì il recupero di prodotti fittili di grande pregio, le nuove scoperte confermavano la qualità di un artigianato specializzato nella realizzazione di protomi, ex voto e di teste a tutto tondo.
I ritrovamenti, il loro studio e l'inquadramento cronologico assumono comunque particolare rilievo perché il giacimento abbia un futuro di tutela e seri interventi di ricerca, non appena come appare nelle intenzioni - l'attracco delle navi di linea verrà spostato nel Porto canale e il porto di via Roma verrà destinato, con operazioni di bonifica, a scopi turistici.
Le strutture sommerse di Egnazia: una rilettura. Alcune strutture sommerse nell'insenatura a nord di Egnazia (Brindisi) sono state oggetto di un'approfondita indagine presentata da Rita Auriemma (Università di Lecce). L'antico centro apulo, che conosce varie fasi di occupazione dall'età protostorica al medioevo, appare dotato di strutture portuali databili alla prima età augustea (I sec. a.C.). L'analisi di questi resti ha apportato nuove informazioni sulle tecniche costruttive, che trovano un preciso riscontro con quelle descritte da Vitruvio peri porti romani in cementizio.
Le evidenze sommerse nell'insenatura a nord dell'acropoli, già note grazie a restituzioni aerofotografiche e ad indagini subacquee, sono state ora oggetto di un sistematico rilievo diretto e di analisi. I dati acquisiti hanno permesso di verificare la pertinenza dei resti a strutture portuali di età romana, confutando posizioni recenti che escludevano tale funzione, e di confermare una serie di nuove informazioni circa tipologie edilizie e tecniche costruttive impiegate, già note altrove. Da segnalare, ad esempio, il sistema di ancoraggio della cassaforma lignea al fondale roccioso, ottenuto con montanti perimetrali dotati di punte metalliche, ancora in sito benché fortemente deteriorate. L'accorgimento, che sembrava esclusivo di costruzioni su fondali sabbiosi, trova ora un significativo confronto nel molo di S. Marco di Castellabate presso Salerno (in corso di pubblicazione da parte di A. Benini), in cui si riscontrano altre analogie con le evidenze egnatine. Le strutture sommerse e quelle presenti lungo la battigia, andando ad inscriversi in un diverso quadro ambientale, costringono inoltre ad un ripensamento delle variazioni della linea di costa e del livello dell'Adriatico. Alcune riflessioni merita infine la cronologia dell'impianto portuale: la prima età augustea, fortemente suggerita da sistemi, tecniche e materiali costruttivi, troverebbe un suggestivo richiamo nella presenza di Agrippa, patrono del municipio di Egnazia.
Archeologia subacquea e umida di Venezia: 15 anni di ricerche (1987-2001) Luigi Fozzati (Soprintendenza archeologica del Veneto) ha presentato gli ultimi avanzamenti della Carta archeologica e l'avvio di una nuova Carta informatizzata per la mappatura del territorio sommerso della laguna di Venezia. La Carta archeologica informatizzata consente di gestire su una base cartografica digitalizzata tutte le informazioni relative ai siti e costituisce il primo esempio in Italia di cartografia archeologica subacquea applicata.
Gli studi e le ricerche condotti a partire dal '700 hanno permesso di valutare l'effettiva consistenza del patrimonio sommerso nella laguna di Venezia, che si è ormai imposta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali come area di rischio archeologico di primaria importanza. La raccolta di informazioni ha rappresentato la prima fase di costruzione del la carta archeologica della laguna, con avvio del sottoprogetto Carta Archeologica Informatizzata della Laguna di Venezia nell'ambito del più generale Progetto AVA (Archeologia Veneziana delle Acque, avviato nel 1988 allo scopo di realizzare la completa mappatura, documentazione, tutela e valorizzazione del territorio lagunare.
Il sottoprogetto della Carta Archeologica Informatizzata della laguna di Venezia è basato su una base cartografica digitalizzata, che gestisce le informazioni relative ai siti archeologici utilizzando le tecnologie multimediali: esso costituisce dunque il primo esempio in Italia di cartografia archeologica subacquea applicata, che consente di attuare una moderna e corretta pianificazione territoriale, dove il sistema beni culturali occupa finalmente il primo posto.
L'aggiornamento è in fase esecutiva dalla metà del 1996 e persegue un doppio risultato: da una
parte la migliore definizione delle aree a rischio, dall'altra la costituzione della carta dei siti archeologici, in parte già realizzata. I risultati raggiunti hanno consentito di progettare nuove linee di sviluppo della cartografia archeologica veneziana: la necessità di mappare tutti i sottoservizi finora realizzati e di redigere la carta archeologica puntuale dei centri storici di Venezia e Chioggia, dove l'intero sviluppo urbano è a totale rischio archeologico.
I relitti di san Marco in Bocca Lama, Venezia. Rapporto preliminare. di Marco d'Agostino (Consorzio Venezia Nuova) L'area, occupata dalla galea e da un'altra imbarcazione da trasporto, una rascona, è stata isolata dal mare con delle paratie, che hanno permesso di condurre all'asciutto buona parte delle indagini. Le due imbarcazioni furono zavorrate e affondate nel 1338 dai monaci che risiedevano sull'isola (all'epoca ancora emersa), nel tentativo di rialzarne le rive. La scoperta è di importanza straordinaria in quanto si tratta dell'unica galea veneziana finora rinvenuta.
La galea veneziana (l'unica sinora ritrovata ed un' altra imbarcazione del XIV secolo vennero concessi alla comunità monastica che viveva sull'isola, la quale era ormai assediata dalle acque. I due scafi, dopo un sistematico lavoro di resezione dell'opera viva, furono affondati e bloccati al fondale, in posizione parallela, con palificate perimetrali. Ottenute così due grandi "casseforme", i due scafi furono riempiti di inerti e terra in modo da riguadagnare spazio sulle acque e ritardare l'erosione. Per le ricerche si è fatto ricorso ad una palancolata con cui l'area è stata recintata. In una prima fase è stato effettuato lo scavo in immersione; in seguito l'area è stata prosciugata con le idrovore in modo da effettuare la documentazione all'asciutto (con fotogrammetrie riprese dal braccio di una gru), avendo cura di irrorare continuamente i legni per evitarne il disseccamento.
Archeologia subacquea di Burano, Laguna di Venezia - Claudia Pizzinato (AIA Sub)
In particolare le ricerche hanno interessato una probabile strada (o camminamento) di epoca romana, formata da pali e tavole in legno, che attraversa il canale per circa 40 metri, oltre a un'opera di arginatura (costituita da pali e tavole infisse verticalmente, colmati da terra e frammenti ceramici vari databili alla metà del Il sec. d.C.) sul margine meridionale dell'isola, alla cosiddetta Darsena della Giudecca.
L'areale lagunare dell'isola di Burano è oggetto da alcuni anni di indagini archeologiche, preventive alla realizzazione di darsene, tra i cui risultati di questi controlli il ritrovamento di una probabile strada o camminamento di epoca romana, riutilizzato in età tardo antica o alto medievale e la "Darsena della Giudecca", un'opera di arginatura sul margine meridionale dell' isola.
Il camminamento si trova nel canale che divide le isole di Burano e Mazzorbo, e si estende in modo discontinuo per circa 40 metri attraversando il canale, in senso perpendicolare al suo corso. I materiali rinvenuti sono costituiti principalmente da pali, tavole e materiale da costruzione riferibili al I-II secolo d.C. L'analisi del C14 ha restituito una datazione rileribile per le tavole al IX secolo e per i pali al II d.C.: è quindi ipotizzabile che si tratti di un riutilizzo della stessa struttura e che le tavole siano state poste in opera nella seconda fase per ristabilire il transito. Questi dati trovano conferma anche in notizie relative al IX secolo.
La "Darsena della Giudecca", ancora in corso di studio, si intestava sull'attuale fondamenta che si affaccia sulla laguna e aveva una conformazione ad "U" con la parte concava rivolta all esterno e i due allineamenti che si dipartivano quasi dalla riva. Era costituita da pali e tavole infisse verticalmente, mentre lo spazio tra gli elementi lignei era riempito da frammenti ceramici, principalmente ceramica comune, anfore di produzione italica e anfore di produzione africana, tutti databili alla metà del II sec. d.C. Sembra plausibile che si tratti di un'arginatura, probabilmente di epoca romana, costruita a difesa dell'isola dai venti di bora, che su questo versante spirano con particolare vigore.
Relazione preliminare della prima campagna di
studio su relitto del XIX secolo, Carlo Beltrame e Dario
Gaddi
In località Bibione (S. Michele al Tagliamento - VE) si
è svolta una campagna d'indagine archeologica, dopo
il recupero di una carronata (cannone navale corto)
d'età napoleonica da parte di un peschereccio.
La campagna,era stata organizzata tra maggio e giugno 2001, dal centro NAUSICAA di Venezia per verificare una zona allargo di Lignano, dalla quale un peschereccio aveva recuperato, a più riprese, una carronata di età napoleonica e vari oggetti.
Una prima prospezione strumentale con side-scan sonar ha portato all'individuazione di un relitto e di altre carronate sparse su una vasta area. Le indagini sono proseguite con il rilevamento delle bocche da fuoco e con la pulizia superficiale della parte di relitto che affiorava dal fondo. Su questa è stato effettuato un rilievo fotogrammetrico. Il giacimento è costituito da un cumulo di zavorra formato da pani di ghisa, palle di cannone e vari oggetti in disuso.
La pulizia della carronata recuperata dal peschereccio ha permesso di leggere il punzone che ha portato a sua volta all' identificazione della nave come il brick napoleonico Mercure, affondato in uno scontro a fuoco con una flotta inglese nella "battaglia di Grado", il 22 febbraio del 1812
L 'archeologia subacquea lacustre del bacino gardesano. Risultati e prospettive della ricerca. di Francesca Bressan e Luigi Fozzati che hanno offerto una sintesi delle ultime campagne (1998-2101) effettuate nello specchio lacustre dove carotaggi preliminari e saggi di scavo hanno permesso di individuare depositi archeologici nel fondo.
Nell'ambito della salvaguardia dei siti a rischio, in occasione d'importanti opere subacquee effettuate in prossimità delle rive orientali del lago di Garda, la Soprintendenza archeologica per il Veneto - Nausicaa (Nucleo di archeologia umida subacquea Italia centro alto Adriatico) ha, infatti, richiesto indagini preventive nelle aree in cui si presumeva esistessero abitati perilacustri. Tra i siti terrestri e subacquei localizzati, si segnalano i resti sommersi di un abitato palafitticolo del Bronzo antico e medio, individuato presso Cisano (Bardolino - VR).
Malcesine, Lago di Garda: indagine preliminare
su un relitto di epoca storica
(Massimo
Capulli)
Un nuovo relitto è stato rinvenuto a 50
metri di profondità nelle acque antistanti Malcesine, sulla
sponda veronese del Benaco. Le ricerche, complicate dalla
profondità hanno permesso di localizzare una porzione dello
scafo che si presenta in linea di navigazione, all'incirca parallelo
alla costa: l'imbarcazione, risulta infatti priva della parte
prodiera e di proporne
una prima datazione all'età moderna, probabilmente al
XVIII-XIX secolo.
Vasellame bronzeo decorato di età romana
da Camarina (Sicilia). Notizie
preliminari.
Giovanni Di Stefano
Nell'agosto 1999 nella baia sottostante l'acropoli di Camarina
(Scoglitti - RG) è stato rinvenuto casualmente a sud dei
grandi relitti monumentali un gruppo di vasi in bronzo (brocche,
secchi, bottiglie, bracieri, patere) decorati con figure
antropomorfe, alcune lucerne e una statuetta di Mercurio, sempre in
bronzo. Il tutto probabilmente facente parte del corredo di bordo di
una ricca nave naufragata. Nell'area di rinvenimento dei bronzi
è stata effettuata una breve campagna di scavi (nov. 1999),
che ha consentito il recupero di altre parti di vasellame. Il
vasellame comprende brocche, secchi, bottiglie, bracieri e patere da
mensa, finemente decorati con figure antropomorfe (teste di meduse
umanizzate, teste di menadi con berretti frigi, busti di Iside),
nonché lampade in bronzo,con i manici decorati. Sia i vasi che
le lampade possono confrontarsi con le migliori produzioni campane di
fine I - inizi II sec. d.C. Con la breve campagna di scavi è
stato possibile accertare che il vasellame, forse originariamente
conservato in una cassapanca, le lucerne e le statue, forse del
larario di bordo, vennero perduti per un versamento di carico intorno
ai primi decenni del II sec. d.C.
Giuliano Volpe (Università di Foggia) ha presentato i primi risultati di uno scavo condotto nell'estate del 1991 in Francia dal DRASSM e condiretto con Luc Long. Si tratta del relitto La Ciotat 3, individuato a 57 metri di profondità, con un carico di anfore Dressel 1 e di ceramica comune. Lo scavo ha permesso il recupero di oltre 250 anfore Dressel 1 (seconda metà II sec. a.C.), nonostante che un pesante saccheggio abbia danneggiato lo strato superiore del carico. Il particolare interesse del relitto è dato dalla presenza di numerosi bolli sulle anse delle anfore, quasi tutti relativi a nomi di schiavi di origine greca impegnati nella produzione di questi contenitori.
Sul campione attualmente disponibile quasi la metà dei contenitori risulta infatti bollato. Sono attestati oltre venti tipi di bolli diversi, relativi a nomi grecanici di schiavi impegnati nella produzione delle anfore: i bolli più ricorrenti sono quelli di: ALEXA, DIESC, NAEPOR, PARNA. PHILO. PHILO ecc.
Ceramica e relitti di età repubblicana: cronologia comparata di Giuliana Galli (A.I.A.Sub). L'intervento sulla ceramica e i relitti d'età romana repubblicana (III-I sec. a.C.) ha aperto l'argomento del commercio antico. Uno studio comparativo condotto su alcuni carichi di relitti di navi d'età tardo-repubblicana, rinvenuti tra Italia, Francia e Spagna, prendendo in considerazione non solo le anfore e la ceramica a vernice nera, ma anche la ceramica cosiddetta "comune", il materiale documentario, grafico e fotografico, delle forme presenti nei vari relitti è confluito in una tavola sinottica, nel tentativo di individuare eventuali "servizi" da mensa e di istituire una relazione tra fogge e funzioni.
Il passaggio successivo è stata la classificazione tipologica (riferita allo studio sulla ceramica campana di J.P. Morel), inserita in un database di seriazione, fornito dall'Università tedesca di Koeln. La tabella sinottica costruita con i diversi tipi di ceramica e i diversi relitti rispettivamente in ascissa e in ordinata, evidenzia l'evoluzione delle forme, considerate nella loro durata "media" di vita, attraverso un range cronologico di circa cento anni. Grazie ad ulteriori riferimenti cronologici, provenienti dalla necropoli celtica di Ornavamo (NO), Galli è giunta ad una proposta di revisione dei dati cronologici di alcuni relitti.
Il commercio marittimo dei laterizi: alcune considerazioni per le rotte alto-tirreniche. Simonetta Menchelli (Università di Pisa) Anche materiali "minori" come i laterizi erano oggetto di un ricco commercio marittimo. Tramite la navigazione fluviale e di piccolo cabotaggio, ma anche con il commercio a grande scala da e verso Roma, le tegole e i mattoni costituivano un carico terziario, accanto agli altri prodotti nordetruschi di maggiore successo commerciale (marmo, legname, terra sigillata, anfore vinarie).
L'intervento, ha avuto come oggetto l'import-export di laterizi nell' Etruria settentrionale costiera, con particolare riferimento ai centri urbani di Luna, Luca, Pisae e Volaterrae, e ai rispettivi territori.
Bolli laterizi da tempo editi e di più recente acquisizione dimostrano che, fra gli ultimi decenni a.C. e la prima età imperiale, nell'Etruria settentrionale costiera avviarono la produzione figlinae dalla complessa organizzazione gerarchica, in cui lavoravano schiavi provenienti dall'Oriente mediterraneo. Come i coevi ateliers pisani di terra sigillata, tali manifatture erano gestite dalle classi dirigenti municipali (L. Titinius Glauous Lucretianus a Loita, i Venuleii e i Rasinii a Pisae, i Caecina a Volaterrae): laterizi bollati da questi personaggi risultano in parte utilizzati in loco per gli insediamenti rurali, per le residenze gentilizie e per fini energetici (acquedotto di Caldaccoli, Pisa; Teatro di Volterra) ed in parte inseriti nei circuiti commerciali altotirrenici.
Nella prima età imperiale per le tegole e i mattoni bollati da gente dell'Etruria settentrionale costiera è infatti documentata una circolazione lungo le rotte tirreniche, da Luni all'Etruria centrale, a Roma, all'Isola d'Elba, in Corsica e in Sardegna. Poiché notoriamente i laterizi hanno un alto coefficiente di stivaggio, anche se imbarcati come zavorra dovevano avere un seppur scarso valore commerciale, che ne rendesse conveniente il carico. Mediante i medesimi circuiti commerciali nell'Etruria settentrionale giungevano tegole e mattoni prodotti nelle manifatture urbane.
Menchelli ha perciò preso in esame le varie dinamiche commerciali in cui erano coinvolti i laterizi nelle rotte alto-tirreniche e le diverse modalità di distribuzione: dalla navigazione fluviale e di piccolo cabotaggio con circolazione intermunicipale, al commercio a grande scala da e verso Roma, in cui le tegole e i mattoni costituivano il carico terziario accanto agli altri prodotti nord-etruschi di maggiore successo (marmo, legname, terra sigillata, anfore vinarie).
Impianti per la lavorazione del pesce conservato al Giglio e a Giannutri. Paola Rendini (Soprintendenza archeologica della Toscana)
Recenti interventi a fine di tutela hanno portato alla scoperta di strutture murarie inerenti ad impianti per la lavorazione del pesce di età romana, sull'isolotto della Torre del Campese, lungo la costa orientale del Giglio e a ridosso delle strutture portuali di Cala Maestra a Giannutri.
Gli impianti permettono di ampliare il quadro, noto e già articolato, sulla diffusione degli apprestamenti destinati all'allevamento e alla lavorazione del pesce in generale e in particolare nelle due isole dell'arcipelago toscano), in cui la presenza di questi complessi produttivi sottolinea l'importanza del pescato nei programmi di valorizzazione e sviluppo anche delle ville imperiali. Rendini ha inoltre riesaminato le problematiche inerenti agli apprestamenti portuali di Giglio e Giannutri alla luce degli studi e delle scoperte più recenti.
Nuovi dati sulla tonnara di Baratti di Elisabeth I. Shepherd (Soprintendenza archeologica di Ostia) e Luisa Dallai (Università di Siena)
Le autrici hanno preso un passo di Strabone (V, 2, C 223), il quale, nel descrivere il suo approdo nel porto della città di Populonia negli anni del principato di Augusto, segnalava che «sotto il promontorio si trova anche un'installazione per l'avvistamento dei tonni», definita col termine thynnoskopeion.
La tradizione colloca questo punto di avvistamento nei pressi della Punta delle Tonnarelle, che chiude a sud il golfo di Baratti; il toponimo moderno ricorda l'attività della tonnara di Baratti, attiva fino alla metà del XX secolo. L'identificazione si basava esclusivamente su una presunta identità di vocazione del sito, senza alcun riscontro con la realtà archeologica. Dalla revisione della documentazione, conservata nell'Archivio Storico della Soprintendenza Archeologica della Toscana, relativa al recupero avvenuto negli anni '60 nel Golfo di Baratti di un noto gruppo di ancore romane (una delle quali con bollo di L. Ferranius Celer) è stato individuata il luogo di rinvenimento e le modalità di deposizione delle ancore sul fondale, ipotizzandone l'uso come pesi da rete.
Pesca e navigazione fluviale lungo l'Auser Serchio in età romana. I materiali dalla piana di Lucca (Giulio Ciampoltrini e Augusto Andreotti). Ricerche di superficie e scavi condotti nella piana del Bientina (fra Pontedera e Lucca) hanno permesso di recuperare una quantità significativa di manufatti e dati riconducibili all'attività di pesca e alla navigazione che si svolgeva lungo il ramo deIl'Auser (l'antico corso del Serchio) che anticamente sboccava nel l'Arno proprio all'altezza di Bientina (PI). Il complesso dei materiali comprende soprattutto pesi da rete, ami e aghi in bronzo e alcuni pesi per bilancia in piombo, tracce evidenti dell'attività di pesca, e probabilmente anche commerciale, che in età romana si svolgeva lungo un fiume dell'Etruria settentrionale.
Un complesso di manufatti riconducibili all'attività di pesca e alla navigazione fluviale che si svolgeva lungo il ramo dell'Auser - Serchio che sboccava in Arno. I materiali sono provenienti da ricerche di superficie e indagini di scavo condotte nella piana del Bientina. A questi ritrovamenti si è aggiunto un singolare lotto di oggetti in bronzo, ritrovato negli anni Sessanta in circostanze oscure, che testimonia un piccolo commercio fluviale di manufatti in bronzo, destinati soprattutto all'attività di pesca (aghi da rete, ami) e che potrebbe aver formato il carico di una barca fluviale dissolta. Manufatti in piombo (principalmente pesi da rete di varia tipologia), aghi e ami in bronzo e una rilevante quantità di ancorotti in pietra possono tratteggiare &emdash; anche per la concreta possibilità di correlare tipologicamente i materiali da recuperi di superficie con quelli da regolari indagini di scavo &emdash; aspetti significativi dell'attività di pesca che in età romana si svolgeva lungo un fiume dell'Etruria settentrionale, mentre la singolare concentrazione, in alcuni insediamenti disposti lungo il fiume, di pesi per bilancia (in piombo), fa sospettare le dimensioni cospicue del piccolo commercio che vi si svolgeva.
L'attività produttiva della gens Aquinia (Carlotta Bigagli) Lo scopo del lavoro è stato quello d'individuare l'area di distribuzione dei lingotti di piombo di provenienza spagnola prodotti dalla gens Aquinia, una potente famiglia della Hispania Tarraconensis la cui attività si sviluppò nel distretto minerario di Carthago Nova (Cartagena, Spagna) intorno al I sec. a.C., periodo in cui il traffico commerciale marittimo dei lingotti di piombo di produzione spagnola è molto intenso e interessa tutto il Mediterraneo.
I prodotti minerari della geni Aquinia partivano da Cartagena, la città portuale più importante della penisola iberica per lo sfruttamento minerario tra la fine del II e il I sec. a.C.; nelle sue vicinanze infatti, è situata la Sierra Minera di Carthago Nova. Miniere già sfruttate dagli Iberi e dai Cartaginesi, che con la conquista romana della città conobbero un tale incremento di estrazione da provocare una forte ondata migratoria, soprattutto di famiglie campane e centro-italiche. Tra i bolli su lingotti di piombo provenienti da relitti, sono particolarmente diffusi quelli della gens Aquinia, rappresentata da due suoi esponenti: M-AQVINI.C-F, rinvenuto su 15 lingotti del relitto di Bajo de Dentro, e C-AQVINI-M-F, rinvenuto su 13 lingotti del relitto di Cartagena B, su 3 pani ripescati lungo la Costas del Garraf (Tarragona) e su un lingotto facente parte del carico del relitto di Escombreras 3.
Baratti 2001 ": uso di tecnologie avanzate nella ricerca di giacimenti archeologici sottomarini,di Pamela Gambogi. Nell'arco del 2001 si sono svolte nella baia di Baratti e tra la costa di Piombino e l'isola d'Elba alcune prospezioni volte a testare l'uso di scan sonar e di AUV (cioè veicoli autonomi sottomarini), per il rilievo dei fondali applicato alla ricerca di giacimenti archeologici profondi. In particolare è stato rilevato un nuovo relitto di nave oneraria, denominato Follonica Nord, con anfore di tipo Dressel 1B e Dressel 1C (fine II - inizi I sec. a.C.), in buono stato di conservazione, nonostante le tracce evidenti del passaggio di clandestini.
Il Progetto è stato avviato in collaborazione fra la Soprintendenza Archeologica della Toscana, l'American Academy in Rome, il Massachusetts Institute of Technology e il Saclant Undersea Research Centre (NATO) sede di La Spezia, per il rilevamento di giacimenti archeologici sommersi con uso di scan sonar e successivamente di ROV. I primi monitoraggi si sono svolti in febbraio e in agosto di quest'anno: la nave Manning del Saclant Centre, ha compiuto una serie di monitoraggi con scan sonar a profondità variabili fra i 15 e i 60 metri, allargo di Piombino; in profondità fino ai 25 metri, il Nucleo Operativo Subacqueo SAT ha effettuato immersioni di controllo. I tratti di fondale indagati si trovano rispettivamente nella baia di Baratti, in particolare la zona del relitto del Pozzino, già indagato dalla Soprintendenza negli anni 80 e '90, le cui coordinate hanno avuto funzione di punto di riferimento per testare la restituzione del tracciato dello) scan sonar, nel tratto di mare a largo di Cala Piccione, a sud di Baratti, e nello specchio di mare antistante la centrale ENEL di Piombino.
In quest'ultima zona si è individuato, su segnalazione di subacquei sportivi, un probabile relitto di oneraria, costituito prevalentemente da Dressel 1B e Dressel 1C, che conserva, nonostante le tracce evidenti del passaggio di clandestini, una notevole estensione e un buono stato di conservazione. La campagna di agosto, in particolare, ha permesso di testare l'uso del ROV, in combinazione con boe GPS per la delimitazione dell'area per aumentare la precisione di rilevamento della rotta del natante. Una prossima, terza fase prevede test con AUV (Autonomous Underwater Vehicle), veicoli sottomarini di ultima generazione in grado di percorrere in totale autonomia una rotta precedentemente impostata.
Aspetti di nautica antica (Stefano Medas - Istiaen). Oltre alla ricerca archeologica, importanti dati vengono dalle fonti scritte. Stefano Medas ha cercato di mettere in luce alcuni aspetti di nautica antica presenti nell'lndiké dello storico greco Arriano (circa 95-180 d.C.), uno dei più affascinanti racconti per mare dell'antichità, dove si narra il viaggio di Nearco, che condusse la celebre spedizione marittima alle foci dell'indo.
La seconda parte dell'Indiké di Arriano contiene il resoconto del viaggio di Nearco, l'ammiraglio di Alessandro Magno che nel 325 a.C. condusse la celebre spedizione marittima dalle foci dell'indo fino al Golfo Persico. Medas ne ha proposto una lettura alla ricerca degli aspetti che possano effettivamente ricondursi ad un'esperienza nautica vissuta, nel tentativo di individuare la reale natura dello scritto di Nearco, che Arriano ricorda più volte essere la sua fonte per questa parte dell'opera.
È ben noto, ha sottolineato l'autore, che i resoconti di viaggio dell'antichità si presentano sostanzialmente come degli elaborati a tavolino, in cui l'impostazione letteraria domina lo scarno documento nautico redatto da naviganti ad uso di altri naviganti. In questi documenti, le effettive indicazioni di carattere nautico appaiono stemperate all'interno di un genere letterario basato sui principi della geografia descrittiva, nel quale si inseriscono anche le notizie di carattere storico, etnografico e naturalistico. L'Indiké arrianea ripropone il problema: dalla dimensione letteraria emergono i riferimenti specifici a diversi momenti e modalità della navigazione, alle soluzioni pratiche messe in atto per affrontare il mare lasciando trasparire tutta la concretezza dell'esperienza vissuta.
Lembos, elementi per una ricerca. (Adrian Anastasi) Sempre nell'ambito della nautica antica si inserisce l'intervento incentrato su due particolari tipologie d'imbarcazioni, definite liburna e lembos, entrambe associate a popolazioni illiriche. Descritte come navi da guerra, piccole e veloci, non è ancora possibile affermare con certezza se si tratti dello stesso tipo d'imbarcazione.
Le fonti, dal III sec, fino alla seconda metà del I a.C., individuano due particolari tipologie d'imbarcazione: la libarna, il cui nome deriva evidentemente da quello del popolo dei Liburni, e il lembos, genericamente associato con le popolazioni illiriche (Liburni, Daorsi, Ardiei e forse i Labeati).
Queste due particolari tipologie d'imbarcazione sono presentate dalle fonti scritte come navi da guerra, piccole e veloci, caratterizzate da un bordo basso, con la prua e la poppa alte e arcuate; gli studiosi tuttavia non sono ancora concordi se lembos e liburna siano lo stesso tipo di nave.
Sulla base dei dati provenienti dalle fonti letterarie, dalle informazioni deducibili dalle rappresentazioni navali presenti su alcune monete illiriche ed in assenza di documentazione archeologica, non è possibile a tutt'oggi proporre una ricostruzione del lemhos.
Su questi elementi ed altri, associati anche alle "zone di alta probabilità di ritrovamento", (elaborate valutando le potenzialità archeologiche subacquee della costa albanese), Anastasi ritiene che si possa costruire un'ipotesi di lavoro e di ricerca.
Trasporto e commercio di opere d'arte in epoca medievale e moderna: il contributo dell'archeologia subacquea, Francesco Paolo Arata (A.I.A.Sub).
Partendo dalle evidenze archeologiche e storiche, risalenti a epoca tardoantica (IV-V sec. d.C.) fino ai primi decenni del XIX secolo, sono state sempre affidate alla navigazione sculture singole o intere collezioni d'arte, nonostante gli elevati rischi di naufragio: dai ritrovamenti di Punta del Serrone (Brindisi) Barletta e Malamocco alle peripezie dei marmi del Partenone (i celebri Elgin's marbles)...
Un excursus attraverso i dati archeologici, storici e d'archivio per delineare il fenomeno dei trasporto e del commercio di opere d'arte antica in epoca medioevale e moderna. Partendo da evidenze di età tardo-antica (Punta del Serrone, Baratti, ecc.), Arata ha esaminato le testimonianze medievali dirette (Barletta, Malamocco) ed indirette, come offerto dalla presenza a Venezia, Genova, Pisa, Amalfi di opere d'arte provenienti dai diversi centri del mondo classico
Di particolare importanza appare il flusso di opere d'arte giunte a Venezia dall'Oriente greco e dalla Grecia continentale, e da qui diffuse in Italia settentrionale ed in Europa, contribuendo in maniera fondamentale alla rinascita della cultura classica e alla formazione del gusto artistico moderno.
A partire dal XV secolo, un significativo ed ininterrotto flusso di opere d'arte, di cui si ha ampia documentazione, si muove via mare da Roma e dalla penisola italiana verso le principali corti principesche e le aristocrazie d'Europa. Lo scorcio del XVIII secolo e i primi decenni del XIX offrono testimonianze della tendenza di affidare sculture singole o intere collezioni d'arte, anche di particolare pregio ed importanza, alla navigazione marittima non esente da rischi e da possibili naufragi.
![]()
inserimento del 28 maggio 2002
www.archeosub.it